Just give me one thing that I can hold on to
To believe in this living is just a hard way to go
(John Prine, Angel from Montgomery)
La prima cosa che avevo visto era stata il soffitto dell’ospedale. Avevo saggiato con i polpastrelli la consistenza ruvida e avevo tastato con la punta della lingua l’odore di varechina delle lenzuola bianche, poi avevo tentato di girarmi. Una fitta al torace mi aveva fatto desistere da quel tentativo. Era come se avessi avuto una lancia conficcata nel costato che mi trapassava da parte a parte. Avevo cessato di compiere ogni movimento cominciando a dosare anche la frequenza dei respiri e puntellando gli occhi al soffitto.
Fuori era buio. La stanza era illuminata solo da una luce fioca che giungeva da sinistra e si disperdeva tenue lungo il soffitto. Era buio ma non era notte, piuttosto un freddo pomeriggio di fine inverno o inizio primavera, da tazza di tè caldo con biscotti e limone a parte. Ero rimasto immobile a lungo. Forse mi ero anche appisolato, sognando convulsamente il traffico della Interstate 95 che tagliava in due Baltimora.
Poi, ancora intorpidito dal dormiveglia avevo deciso di ritentare l’operazione: avevo raccolto le energie e avevo cominciato a girare lentamente il collo verso sinistra finché non ero riuscito ad appoggiare completamente la guancia sul cuscino. A fianco del letto c’era una sedia, sulla spalliera la giacca di Cheryl, poco più in là una porta che dava su un corridoio illuminato. Se non altro avevo capito da dove arrivava la luce fioca che illuminava la stanza. Avevo raccolto le energie e avevo cominciato a girare lentamente il collo per raggiungere con lo sguardo il lato sinistro della stanza. Era stata un’operazione lunga e dolorosa. Ero ripassato con lo sguardo lungo il soffitto e avevo cominciato a scendere lentamente. Su quel lato c’era una finestra abbastanza ampia. Del sole neppure l’ombra, in compenso pioveva… una pioggia atlantica, sbatacchiata qua e là da un vento freddo che bagnava la vetrata con maggiore intensità nella parte in basso a destra.
Avevo drizzato le orecchie come un segugio. Percepivo nel crepuscolo rischiarato dai colpi di neon il bisbiglio di un paziente che sussurrava parole rade e sconnesse intervallandole a singhiozzi soffocati. Non riuscivo a distinguere le singole parole, ma solo il loro tenore. Era un sospiro tenue che fluttuava nell’aria, una specie di monologo rantolato e spezzato da violenti colpi di tosse. Poi il bisbiglio era cessato e la stanza era ripiombata nel silenzio.
Avevo fatto ricorso a tutta la mia determinazione e avevo girato nuovamente la testa verso sinistra len-ta-men-te. E mi ero trovato faccia a faccia con Cheryl.
Indossava una tuta verde e una mascherina che le copriva il viso. Ci eravamo guardati, restando in silenzio. Io immaginando il contorno del suo viso, lei fissando la finestra bagnata dalla pioggia. Affilato. Tutto in lei era affilato. Affilato il taglio dei capelli, d’un biondo cinerino, affilato il taglio degli occhi impenetrabili e sfuggenti, affilato il naso, forse un po’ troppo lungo per quel visino. Affilata sì… ma ancora bella. Pareva vivesse i suoi trent’anni con un tocco sbarazzino, nonostante i problemi, le discussioni che spesso sfumavano in litigi, le spese. Pareva che tutte le avversità che la vita ci aveva vomitato addosso avessero per reazione illuminato la sua bellezza conferendole maggior dignità. O forse no… perché i segni dei troppi caffè, dei mille pensieri, delle troppe poche ore di sonno, delle mille discussioni erano facilmente riconoscibili negli occhi troppo dilatati, forse stanchi, nelle borse appena accennate che ne disegnavano il contorno e nelle rughe impercettibili che cominciavano a farsi strada lungo il contorno della bocca e appena sotto le palpebre.
–Come stai?- Mi aveva domandato d’improvviso rompendo un silenzio privo di significati.
Come devo stare? Avevo tentato di rispondere, ma quando avevo raccolto il respiro per spingerlo lungo la trachea, una fitta lancinante mi aveva strozzato la voce in gola.
Ero rimasto in silenzio. Fissandola. Senza parlare.
Nell’altra stanza il rantolo del fantasma aveva ripreso a mugugnare con quel tono baritonale mentre fuori dalla finestra il cielo si era aperto, un cielo traboccante di promesse che rifulgeva di cirri di porpora e d’oro.






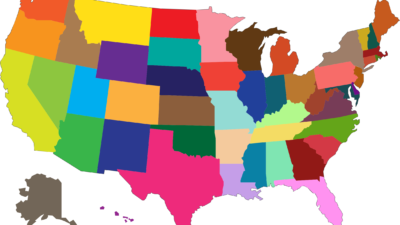
Aggiungi un commento